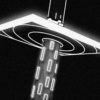La successione è impressionante. Se non si tratta di una campagna ben orchestrata pensata a tavolino, è peggio: significa che il concetto di sostenibilità è totalmente estraneo, culturalmente e geneticamente, a certa impresa.
Il primo passo verso la fine del 2019: nei giorni in cui si ventila la possibilità di introdurre una “plastic tax”, le associazioni dei produttori di plastica monouso pubblicano sui principali quotidiani un avviso a pagamento in cui, fra l’altro, c’è scritto: “I rifiuti costituiscono una enorme riserva di risorse che, se opportunamente gestita e valorizzata, può garantire un approvvigionamento sostenibile e continuo negli anni di materiali ed energia”. Il messaggio è chiaro: più rifiuti si producono, meglio è per l’ambiente e per la società. E questi rifiuti vanno prodotti con continuità, sennò l’approvvigionamento sostenibile si interrompe.
Poi, ai primi di maggio 2020, quando già si sa che gli eventuali aiuti europei per fare fronte agli effetti della pandemia saranno condizionati dalla coerenza con il Green Deal europeo, che ha fra i pilastri principali l’economia circolare, un gruppo di più di 100 aziende pubblica un manifesto[1] dal titolo: “Uscire dalla pandemia con un nuovo green deal per l’Italia”. In questo manifesto si afferma che il riciclo dei rifiuti è “pilastro dell’economia circolare”, quindi del Green Deal europeo. Dunque il problema ambientale dei rifiuti si risolve riciclandoli; corollario: controproducente cercare di produrne di meno, perché il riciclo è pilastro dell’economia circolare.
Infine, il 22 giugno 2020, in una intervista al Corriere della Sera[2], il presidente di una delle aziende italiane leader nel settore della trasformazione degli idrocarburi (da cui si fa la plastica) afferma: “I rifiuti sono il nuovo petrolio, smaltirli costa moltissimo. Noi ne facciamo nuovi prodotti e materie prime per l’industria. Senza emissioni”. L’idea è di produrre idrogeno dai rifiuti di plastica; e di idrogeno, sta scritto nel Green Deal europeo, ce ne vorrà tantissimo se vogliamo eliminare completamente i combustibili fossili. Risultato, a rigore di logica: bisogna produrre tantissima plastica per avere tantissimi rifiuti per fare tantissimo idrogeno.
Questo approccio, più rifiuti ci sono meglio è, trova supporto non solo in quelli che si sono organizzati per produrre gli oggetti e poi, loro stessi, riciclarli – guadagnandoci due volte, il che è comprensibile, ma anche in una visione economica distorta secondo la quale questa operazione fa bene al PIL perché a quello della produzione si aggiunge il valore economico derivante dal riciclo di quello che si è prodotto; e in più si fa bene all’ambiente.
Tutti d’accordo, quindi: produciamo tanti rifiuti e ricicliamoli, e così mettiamo in atto l’economia circolare a cui UE punta. Ma c’è un equivoco di fondo (voluto o non voluto, cambia poco): gli imprenditori citati non considerano che per produrre gli oggetti che poi diventano rifiuti si usano risorse naturali. Per fortuna questo particolare non sfugge ad altri. Infatti, nei documenti della Commissione Europea che definiscono l’economia circolare[3],[4], si legge che i prodotti adatti per una economia circolare che non impatti sul clima e che sia efficiente nell’uso delle risorse devono essere: durevoli, riusabili, ammodernabili, riparabili e con una bassa impronta ecologica. Soddisfatti questi requisiti, i prodotti devono anche essere facilmente riciclabili. Dunque, il riciclo è l’ultimo tassello, quello che dovrebbe avere, in una economia circolare ben realizzata, un ruolo quasi insignificante, grazie al fatto che la quantità di materia da riciclare sarebbe molto piccola, perché nell’economia circolare quello che più conta, oltre all’impronta ecologica dei prodotti, anche la loro durabilità e riparabilità; il che si porta dietro il fatto che vengano riusati più volte, ricondizionati e ammodernati. Insomma, il messaggio dell’economia circolare si può condensare nel motto: il prodotto più sostenibile che ci sia è quello che non si produce, perché non è necessario.
E questa è una vera rivoluzione, perché toglie di mezzo quello che, sì, è un pilastro, il pilastro dell’attuale modello economico: il consumismo. Infatti, se i prodotti durano, sono riparabili, riusabili, ammodernabili, se ne comprano di meno e se ne producono di meno. E in compenso però aumentano le attività legate al prolungamento del loro ciclo di vita. Ed è così che si salva il pianeta e si crea nuova occupazione che compensa quella legata alla produzione (comunque sempre più ridotta dall’estendersi dell’uso dei robot).
Ma l’abbandono del consumismo è contro non soltanto il modello economico corrente, è anche contro gli interessi a breve di quelle aziende che inondano il mercato con una sempre crescente quantità di prodotti, in coerenza con il principio della crescita indefinita. Ecco perché puntano sul riciclo come motore: più riciclo implica più produzione di ciò che si deve riciclare.
Ma che c’è di male nel riciclo? Il male è che riciclare – va sempre tenuto ben presente – costa energia e materia, quindi non è privo di impatto ambientale, e maggiore è la quantità di prodotti che si riciclano, più alto è l’impatto ambientale del riciclo. Puntare sul riciclo come motore dell’economia circolare è come se in una città in cui è altissimo il numero di feriti per incidenti stradali agli incroci si reagisse aumentando i posti letto negli ospedali invece di mettere semafori e dissuasori. Aumentare i posti letto in ospedale fa anche crescere il PIL e l’occupazione, direbbe il politico di turno per sostenere questa soluzione.
Per aggirare i concetti-base dell’economia circolare, e continuare a fare i propri interessi contro quelli dell’ambiente e dell’umanità, lasciando credere invece che si stanno rispettando i canoni della sostenibilità ambientale, alcune aziende hanno sperimentato un approccio più sofisticato di quello di cui abbiamo detto prima, ma egualmente, o forse più, dannoso. Esemplare è il caso della Coca-Cola e della Carsberg, come raccontato in un articolo del Guardian[5] online del 16 maggio 2020. Le due multinazionali si avviano verso i contenitori di plastica biodegradabili, l’ideale del riciclo. Bello, vero? Centinaia di milioni, miliardi di contenitori usa-e-getta per fare i quali, oltre all’energia e i materiali per il processo produttivo, occorreranno centinaia di migliaia di ettari per coltivare la materia prima (mais o altro), assieme tonnellate e tonnellate di fertilizzanti, insetticidi, erbicidi e fungicidi, per produrre i quali occorrerà energia e materia, per non parlare della perdita di biodiversità che causano. E ci vorrà tanta acqua. Queste migliaia, forse milioni di ettari, non potranno non venire che dalla deforestazione se non si vuole sottrarre cibo dalle bocche degli affamati (più di ottocento milioni[6], nel 2019) destinando alla plastica la produzione prima diretta a loro, e la deforestazione contribuisce al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. E così non ci sono solo le coltivazioni energetiche a competere con la produzione di cibo, ora anche le coltivazioni di plastica. Certo, un oggetto di plastica biodegradabile è anche carbonio sottratto all’atmosfera, quello che la pianta da cui è stato fatto ha assorbito per crescere, e poi con le bottiglie e le lattine possiamo fare compost che torna nei campi, se le trattiamo opportunamente; vero, ma ciò si ottiene a un prezzo ambientale e sociale troppo alto, tanto alto che gli effetti negativi superano quelli positivi. Anche perché, è bene sottolinearlo, non tutta questa plastica riciclabile va al riciclo; molta finisce comunque per sfuggire alla raccolta differenziata e si disperde in terra e in mare. Ebbene, la biodegradabilità di queste plastiche è garantita con certezza solo nel caso del compostaggio industriale, che comporta il raggiungimento di temperature dell’ordine dei 40-50 °C. Queste temperature non si raggiungono mai in altre condizioni, quindi non sappiamo se – e comunque dopo quanto tempo – questa plastica dispersa in terra e in mare riuscirà a decomporsi.
Non sono solo le due multinazionali citate a mettere in atto processi falsamente sostenibili, in genere preoccupante è la fiducia cieca nella intrinseca sostenibilità dei prodotti di plastica biodegradabili, alimentata da una comunicazione convincente messa in atto dalle aziende. Tipico è il caso delle cialde e capsule compostabili offerte dalle aziende del settore del caffè.
La fiducia è alimentata anche dalla errata informazione erogata, si spera per ignoranza e non per corruzione, dai mezzi di comunicazione. Esemplare fra tutti l’articolo[7] sul Corriere della Sera del 2 agosto 2020, in cui si sostiene che a sostituire le cannucce di plastica attuali debbano essere cannucce monouso in plastica biodegradabile, ponendole sullo stesso piano di quelle riusabili. A nessuno sembra venire in mente, a proposito di cannucce, che prima dell’era della plastica si usava la paglia, gli steli del grano – che sono dei tubicini cavi e che sono uno scarto. Non a caso in inglese cannuccia si dice straw, paglia per l’appunto.
In conclusione occorre che di plastica biodegradabile siano fatti solo tutti i prodotti destinati a durare, non quelli monouso, assicurandosi che la coltivazione della materia prima sia fatta in modo sostenibile; di prodotti monouso non bisogna più neanche parlarne, se non nel caso di quelli strettamente necessari, per esempio per motivi igienico-sanitari.
Quanto detto non significa che il riciclo, intesa come pratica volta a minimizzare l’estrazione delle risorse primarie, sia da combattere. Al contrario. Si tratta di una pratica essenziale, ma che va contestualizzata in relazione alle tipologie di prodotto. Di certo, la quantità di prodotti industriali che entrano nel mercato deve prima di tutto essere minimizzata alla fonte, coerentemente con i principi dell’economia circolare come interpretata nel Green Deal Europeo.
Diversa è la situazione con i rifiuti organici. Per il rifiuto organico “acque reflue” il riciclo è sì pilastro dell’economia circolare, se queste acque sono trattate in modo opportuno, estraendone i nutrienti e rendendoli adatti al loro spargimento nei campi, come in alcune città si comincia a fare. Infatti è indispensabile che si chiuda il più possibile il ciclo dei nutrienti (azoto, fosforo principalmente, ma anche altri), quelli che si trovano nelle acque nere, restituendoli al suolo da cui le piante di cui ci nutriamo, per crescere, li hanno estratti. In questo caso dunque è vero: più rifiuti ricicliamo, ovvero più acque nere trattiamo in modo adeguato, meglio è, senza altre condizioni da soddisfare prima o insieme. E ciò è perfettamente in linea con i principi dell’economia circolare, perché il lavoro di utilizzare e valorizzare al meglio, spremendone fino in fondo le potenzialità, i prodotti alimentari lo ha già fatto il nostro organismo. Ebbene, malgrado sia la sola circostanza in cui il motto “più materiale da riciclare c’è, meglio è”, di questo riciclo si parla poco o niente, e c’è una buona ragione per spiegare il diverso atteggiamento: non si può aumentare indefinitamente la produzione di questi rifiuti, perché ogni essere umano più di tanto non ne può produrre.
Le stesse regole indicate per i prodotti industriali valgono invece per il cibo, che è ormai in gran parte un prodotto industriale, perché industriale è l’attuale agricoltura. Una agricoltura che fa sì che al cibo manchi il rispetto della prima delle condizioni indicate perché un prodotto sia coerente con l’economia circolare: la minimizzazione dell’impatto ambientale per la sua produzione. L’impatto ambientale dell’agricoltura industriale, infatti, è elevatissimo, ed è la principale causa della perdita di biodiversità e della conseguente possibile sesta estinzione. Finché il cibo sarà coltivato con i metodi dell’agricoltura industriale non potrà essere considerato un prodotto coerente con i principi dell’economia circolare, come non lo sono i prodotti industriali monouso e quelli a rapida obsolescenza.
Infine ci sono i rifiuti alimentari, da cui è essenziale recuperare il più possibile i nutrienti in essi contenuti e restituirli ai campi. Quindi qui vale il principio di massimizzazione del riciclo, ma occorre prima minimizzare il flusso di rifiuti alimentari, minimizzando gli sprechi. È del tutto irrazionale, e dannoso all’ambiente, produrre qualcosa che poi si deve buttare, anche se poi si ricicla, perché quello che si può ottenere dal riciclo è sempre di meno di quello che si è immesso per la coltivazione. Quindi, anche per i rifiuti alimentari, riciclare sì, ma solo dopo averne minimizzato le quantità.
Concludendo, come prevedibile molti si stanno impossessando della parola sostenibilità per farne uno strumento di marketing. Il greenwash – il dipingere di verde quello che verde non è – imperversa sempre di più, e ora si cerca pure di vendere l’economia lineare come circolare, con il riciclo caposaldo di questo approccio.
Se continuiamo su questa linea, quella del riciclo come pilastro della sostenibilità e dell’economia circolare, e non come ultima spiaggia – importantissima, ma ultima spiaggia – non andremo molto lontano. Altro che green new deal, piuttosto greenwash new deal.
[1] https://www.corriere.it/economia/aziende/20_maggio_07/manifesto-green-d8e1387c-906e-11ea-b981-878bbbd902eb.shtml
[2] https://www.mairetecnimont.com/sites/default/files/2020-06/Corriere%20della%20Sera%2022-06-20.pdf
[3] https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
[4] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-398-IT-F1-1.Pdf
[5] https://www.theguardian.com/environment/2020/may/16/the-end-of-plastic-new-plant-based-bottles-will-degrade-in-a-year
[6] https://news.un.org/en/story/2019/07/1042411
[7] https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20200802/282144998682529