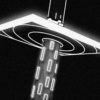Una storia vera, esemplare, di un approccio sbagliato allo sviluppo, basato sulla fede senza limiti nella tecnologia e privo di una visione sistemica. Sbagliato perché ha trascurato un fatto fondamentale: una tecnologia o una tecnica si afferma, e produce effetti positivi, solo se si integra nel sistema socio-economico-culturale, e fisico, nel quale viene inserita.
L’approccio “riduzionista” al progresso ha prodotto guasti non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche ai paesi ecomomicamente avanzati, tanto da essere fra le cause principali del disastro ambientale (e in molti casi anche sociale) a cui stiamo andando incontro. Abbiamo, di volta in volta, adottato le nuove tecnologie senza essere capaci di prevedere e governare il loro reale impatto sui contesti umani e ambientali e sulle delicate relazioni che li mantengono vitali.

Lungo la costa atlantica della Mauritania centinaia di piccole comunità vivono, da secoli, di pesca. Si tratta di pescatori nomadi che praticano un’economia di sussistenza. Fra questi, gli Imraghen.
Può apparire strano l’aggettivo “nomade” applicato ad un pescatore: il nomadismo è incompatibile con l’esercizio della pesca, nei nostri schemi mentali. Il fatto è che il deserto, in Mauritania, arriva fino al mare. Le splendide spiagge che si affacciano sull’Atlantico sono già deserto; e nel deserto non c’è acqua, o ce n’è pochissima. Le tribù di pescatori, quindi, si muovono lungo la costa in cerca di luoghi in cui, come a volte avviene, affiora un po’ d’acqua che si raccoglie in piccole pozze. Il processo di riempimento naturale di queste pozze è molto lento, e la quantità di acqua usata è di solito maggiore della capacità spontanea di reintegro, e la pozza dopo un po’ di tempo si svuota. Periodicamente, dunque, la comunità deve migrare alla ricerca di acqua.
I pescatori nomadi hanno solo delle reti. Essi avanzano nel mare camminando sul fondo sabbioso, si dispongono a semicerchio, e formano una barriera con la rete stesa fra di loro. Aspettano il banco di pesci e lo intrappolano chiudendosi a cerchio.
Non sempre, però, la pesca è fortunata. A volte non c’è pesce, o ce n’è poco. In questi casi i pescatori chiedono aiuto e spesso lo ottengono. Lo ottengono da altri esseri viventi che, nella zona, si trovano pure in difficoltà a causa della scarsità di pesce.

In un articolo apparso sulla rivista Airone, nel 1984, si leggeva[1]: Il sole picchia ed il vento solleva la sabbia finissima che bersaglia senza sosta e dolorosamente i pochi lembi di pelle non ricoperti dai vestiti e dall’«hawli», il turbante mauritano. Insensibile a tutto, una figura si staglia immobile, accovacciata alla turca su una duna: è l’«amchichik» (la vedetta), che scruta attentissimo il mare.
Gli «amchichik» vengono scelti fra gli anziani Imraghen: la presbiopia e l’esperienza senile, infatti, consentono loro di svolgere questo compito meglio di chiunque altro. Durante l’esercizio della sua funzione è severamente proibito rivolgere la parola all’«amchichik», per non interromperne la concentrazione. Nonostante siano bruciati dal sole e coperti di mosche, i loro occhi sono infallibili. Un indizio, anche minimo, come un brulichio fra le onde o una diversa colorazione dell’acqua, è sufficiente per individuare un banco molto distante, e scoprirne tutte le caratteristiche di lunghezza, direzione e composizione.
Un grido si alza improvviso. È l’«amchichik» che, alzatosi di scatto, agita il turbante nero lanciando finalmente il richiamo che tutti aspettano. Il banco di pesce è avvistato. I pescatori si tolgono di furia la tunica ed indossano i costumi da bagno in pelle di capra, o chi può permetterselo in tessuto. Ognuno afferra la sua rete, che è pronta lì sulla spiaggia, assieme al palo che la sostiene, la collega alle estremità con quella del suo vicino di pesca, e tutti avanzano verso l’acqua. Un gruppo viene mandato avanti dal capopesca, a sbarrare la strada ai pesci, mentre l’altro entrerà in acqua subito dopo, per chiudere il cerchio di reti in coda al banco.
Al largo si vedono dei delfini saltare.
Un pescatore, armato di un lungo bastone, entra in mare e comincia a battere furiosamente la superficie. È il segnale. I delfini si avvicinano spingendo il banco verso riva, come cani da pastore. L’operazione ha successo, come sempre: i pesci, spaventati dai cetacei, i loro principali predatori, si dirigono alla cieca verso le secche e i bassi fondali, cercando salvezza. E lì, ad attenderli, sono gli Imraghen.
A questo punto il capo punta la sua fiocina verso le prede ormai in trappola, ed i pescatori aprono a cerchio le reti. Per il pesce non c’è più scampo. La rete viene progressivamente chiusa, ed i pesci catturati.
La parte di banco presa è piccola rispetto all’intero: quella scampata alle reti si trova adesso ad affrontare i delfini che, appena più al largo, attendono ansiosi la quota che loro spetta.
Fra pescatori e delfini si è stabilita una specie di simbiosi: impedendo al banco di sfuggire al largo, il delfino fa da battitore per l’uomo. Gli Imraghen, disgregando il banco, convogliano i pesci che non catturano verso le fauci spalancate dei cetacei.
Allo scopo di migliorare il livello di vita delle comunità di pescatori nomadi e, nello stesso tempo, di avviare un processo di sfruttamento razionale dell’immenso potenziale di cibo solo teoricamente a disposizione della popolazione mauritana, fu avviato alcuni anni fa un progetto di sviluppo. Il miglioramento del livello di vita includeva anche un aspetto particolarmente doloroso. Malgrado in Mauritania la schiavitù fosse stata abolita per legge negli anni ’70, in realtà negli anni ’80 e dopo era ancora viva. I padroni erano generalmente gli appartenenti alle etnie provenienti da nord, dai paesi arabi, i conquistatori. Gli schiavi erano gli appartenenti alle etnie originarie, i neri. Quasi tutte le tribù di pescatori nomadi appartenevano a un padrone. Essi pescavano per lui, che forniva loro le reti e quant’altro servisse per la loro sopravvivenza: acqua quando occorreva, vestiti, cereali, legna per cucinare, eccetera. E ovviamente lasciava loro una po’ del pescato. Il resto, la maggior parte, il padrone veniva a prenderlo con un qualche veicolo e lo portava al mercato di Nouakchott per venderlo.
Nella usuale logica secondo la quale nella tradizione c’è solo ignoranza e nella modernità tutto il bene possibile, il progetto aveva come obiettivo l’introduzione di tecniche di pesca più evolute, quelle che avevano avuto successo nei paesi sviluppati, dando per scontato l’innescarsi spontaneo di un sistema di trasporto e commercializzazione del surplus di pesce che si sarebbe ottenuto. Ciò avrebbe anche affrancato i pescatori dalla schiavitù.
Il progetto fu eseguito da tecnici giapponesi, perché giapponesi erano i fondi, stanziati nel quadro degli aiuti nipponici al terzo mondo e si sviluppò secondo tutte le fasi previste.
Furono innanzitutto identificate le comunità che avrebbero avuto la fortuna ed il privilegio di fare da “test”, ed a queste venne fornito tutto il materiale necessario per compiere il “salto di qualità”: reti di materiale sintetico pressoché indistruttibili, barche di legno e di plastica, motori fuoribordo, ecc.; tutto di produzione giapponese, naturalmente. Del resto così si usa nei progetti di aiuto ai paesi in via di sviluppo: chi mette i soldi li spende, finché può, in casa.
L’équipe giapponese disponeva pure di camion frigorifero a quattro ruote motrici per il trasporto del pesce, attraverso il deserto, alla città più vicina, e di un camion cisterna che faceva la spola per il rifornimento di acqua.
Una delle comunità Imraghen oggetto dell’intervento fu “stanzializzata” in un luogo della costa a circa 60 km da Nouakchott, la capitale. Il periodo di formazione durò due anni, durante i quali ai pescatori fu insegnato ad usare le barche, i motori, le reti e tutto ciò che costituiva il pacchetto tecnologico che veniva loro offerto.
La quantità di pescato aumentò enormemente, rispetto a prima, e i camion frigorifero portavano in città grandi quantità di pesce ogni giorno. I pescatori si liberarono delle loro scomode tende da nomadi e, grazie alla relativa disponibilità economica raggiunta, cominciarono a costruirsi delle baracche di legno, come quelle che avevano visto tutto intorno alla capitale e che, somigliando a quelle in muratura, erano simbolo di benessere.
L’acqua non mancava.
Secondo i tempi previsti, il progetto si concluse. I giapponesi andarono via, lasciando l’attrezzatura da pesca, ma riportando indietro tutti i camion.
Andati via gli esperti, i pescatori non osarono più mettere le barche in mare se non quando c’era calma piatta, cioè molto di rado: non si domina il mare con un mezzo sconosciuto con solo due anni di pratica. Poi i motori cominciarono a guastarsi, e nessuno sapeva ripararli. Il piccolo surplus di pesce pescato in queste condizioni veniva acquistato a cifre irrisorie da quei pochi mercanti che venivano a prenderlo. L’acqua veniva pure da Nouakchott e veniva venduta a prezzi talmente elevati che gli utili provenienti dalla vendita del pesce non erano neanche sufficienti ad assicurare un sia pur minimo approvvigionamento d’acqua dolce.
Le baracche, ormai semidistrutte dalle intemperie, non costituivano più un riparo.
La tribù si era ormai stanzializzata: non voleva abbandonare nel deserto tutta la attrezzatura ed inoltre si era abituata agli aiuti esterni. La sindrome da “assistito” scatta subito.
Quando, quattro anni dopo la fine del progetto, visitai il villaggio, da tre anni nessun nuovo nato era riuscito a sopravvivere, a causa della carenza d’acqua, di cibo e delle condizioni ambientali intollerabili.
Gli antichi padroni erano tornati e con essi lo stato di schiavitù.
I delfini continuavano a rincorrersi all’orizzonte, ma con gli uomini il sodalizio si era spezzato.
[1] F.X. Pelletier, A pesca con i delfini, Airone, 1984