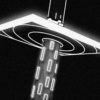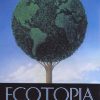Riportiamo su Connettere un articolo di prossima pubblicazione in edizione integrale nel Volume “I Giardini del tè di Dazhangshan” per il XXX Premio Internazionale Carlo Scarpa 2019 promosso dalla Fondazione Benetton, Studi e Ricerche di Treviso.
In attesa che, nella scala temporale che segna la storia del pianeta, la Commission for Stratigraphy (ICS) della International Union of Geological Sciences (IUGS) consideri l’Antropocene epoca geologica distinta dall’Olocene (fig.1), il consenso scientifico intorno alla sua occorrenza è sempre più vasto. L’idea di un’era connotata dalle attività umane con negative, diffuse e globali conseguenze sul funzionamento del sistema Terra, è ampiamente accettata nel dibattito tra scienziati di diverse provenienze culturali. La generale questione non è tanto quella di certificare formalmente l’esistenza di un’“età dell’uomo” – come è definita forzando, a vantaggio della chiarezza, l’etimologia greca utilizzata per le epoche precedenti del Quaternario: il Pleistocene (“molto nuovo”, plêistos kainós) e l’Olocene (“tutto nuovo”, ólo kainós) – quanto precisarne l’origine, i caratteri, gli sviluppi, la possibilità e le modalità di influenzarli.
In termini stratigrafici si può parlare di epoca dell’Antropocene, per l’evidenza della presenza del fallout radioattivo, solo a partire dai primi esperimenti (1945) per le bombe atomiche. Per Paul Crutzen, invece, che per primo nel 2000 ne propose il riconoscimento, l’origine è nella rivoluzione industriale del XVIII secolo e più precisamente nell’invenzione (1784) della macchina a vapore che diede il via all’uso crescente dei combustibili fossili con conseguente rilascio dei gas di serra in atmosfera. Altra tesi rimanda all’inizio della globalizzazione con il viaggio di Cristoforo Colombo, nel 1492, e l’avvio dello scambio ecologico tra “mondi” fino ad allora separati. Ben accreditato è anche il parere che sia stata determinante l’espansione delle società agricole, punto di svolta nell’influenza delle attività umane sulla biosfera dapprima legate alla caccia e raccolta (già a partire dall’uso del fuoco per la deforestazione, antico di 400.000 anni) quindi, progressivamente, alla domesticazione, coltivazione, allevamento e pascolo che da 12.000 anni hanno alterato a fondo gli equilibri planetari che avevano accompagnato la prima fase dell’Olocene. La divaricazione tra Olocene e Antropocene è comunque evidente – e di certo non solo per l’impatto dell’agricoltura – negli anni definiti della “grande accelerazione” come è indicato il repentino balzo in avanti, intorno alla metà del secolo scorso, delle attività umane e della loro incidenza sui processi biogeofisici del pianeta. Impatti che hanno riguardato non soltanto la composizione dell’atmosfera e il clima, ma anche la biodiversità, le trasformazioni d’uso dei suoli, i cicli dei maggiori nutrienti, l’inquinamento della biosfera, la modifica del ciclo delle acque. Il superamento di molti limiti, la multidimensionalità locale e globale, il rapporto sistemico riguardante sia le molteplici cause che gli effetti consentono di individuare gli anni della “grande accelerazione” come inizio dell’Antropocene, quando l’umanità non è più riuscita a controllare molti processi naturali e, da comprimaria nella storia evolutiva della biosfera, ne è divenuta assoluto protagonista determinando, su di essa e su sé stessa, effetti dannosi perduranti e preoccupanti.
Così importanti cambiamenti demografici e ambientali hanno conseguenze non solo ambientali ma anche sociali; profonde al punto che, dall’Antropocene, il rapporto tra natura e cultura si propone come antagonista. Le conseguenze di ciò – di una natura non più risorsa ma limite – determinano la ricerca di soluzioni che si fondano su un approccio integrato che riguardi i fattori diversi che interagiscono su strutture biofisiche, sociali e culturali, prenda atto dei nuovi fenomeni che emergono e delle imprevedibili conseguenze del loro dinamico divenire. La complessità dell’Antropocene, i riflessi globali che ne conseguono, implica che diverse discipline se ne occupino. Saperi scientifici e umanistici: quelli dei filosofi e antropologi, archeologi ed ecologi, storici e ingegneri, agronomi, naturalisti, economisti, sociologi, letterati e artisti; l’ingegno umano e l’espressività della creatività nelle sue diverse forme. Del resto, non solo gli equilibri planetari – propri della Terra come organismo autoregolante, secondo la suggestione “Gaia” di Lovelock-, ma la stessa sopravvivenza della specie umana è messa in discussione da una paventata e ormai prossima “Sesta Estinzione”. Di fronte alle mutate condizioni, alla necessaria rapidità di riflessione e di azione, il pensiero umano, lentamente elaborato nell’Olocene, risulta inadeguato. “L’Antropocene mette fine alla modernità” si è scritto e una radicale trasformazione dei rapporti tra uomo e natura appare urgente. Una mostra che, tra dicembre 2018 e il successivo gennaio, si è tenuta presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha avuto come titolo ilmondoinfine: poteva intendersi come “il mondo infine” o “il mondo, infine” Come un lamento terminale o come annuncio o speranza. Vivere, pensare e operare nell’Antropocene obbliga a scegliere.
I limiti del pianeta
Paul Crutzen ha osservato che tra i primi che riconobbero l’influenza dell’uomo sull’ambiente globale vi furono George Marsh, che nel 1864 con “Man and Nature” aveva dato inizio alla scienza della storia dell’ambiente e che a lungo aveva vissuto in Italia (come ambasciatore USA), e il geologo piemontese Antonio Stoppani che nel 1873 aveva perentoriamente affermato: “Non dubito di proclamare l’era antropozoica. La creazione dell’uomo è l’introduzione di un elemento nuovo nella natura, di una forza affatto sconosciuta … è una nuova forza tellurica” Dell’influenza delle attività umane sugli equilibri planetari, altri se ne occuperanno (tra tutti V.Vernadky il cui contributo del 1926 uscirà pero tardivamente dai confini della Russia sovietica) ma è ancora l’Italia a essere coinvolta. Fondamentale momento di discussione e diffusione sarà, infatti, nel 1972, il rapporto “I limiti dello Sviluppo” che, nella presentazione di Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma che aveva commissionato la ricerca al MIT (Massachussets Institute of Technology), doveva “servire ad accendere…un grande dibattito sui Dilemmi dell’Umanità e catalizzare in energie innovatrici la diffusa sensazione che, con l’avvento dell’era tecnologica, qualcosa di fondamentale deve essere modificato nelle nostre istituzioni e nei nostri comportamenti”. Ben oltre i confini dell’Italia – presumibilmente occasionali, se non fosse per le riflessioni che la centralità mediterranea induce sul rapporto tra natura e cultura– ovunque studi, ricerche, mobilitazioni sociali si confronteranno con il superamento dei limiti ambientali, con la definizione degli squilibri planetari, delle cause e delle conseguenze presenti o attese. In tal senso importante è la definizione, nel 2009, dei “Limiti del Pianeta” (Planetary Boundaries, PB): Nove parametri (cambiamento climatico; perdita di biodiversità; diminuzione dell’ozono stratosferico, acidificazione degli oceani; flussi biogeochimici e cicli dell’ Fosforo e dell’Azoto; uso globale dell’acqua dolce; cambiamenti d’uso del suolo; incremento dell’aerosol atmosferico, inquinamento chimico) che definiscono, i confini dei “safe operating spaces”, degli spazi di sicurezza da rispettare per non danneggiare gravemente la biosfera e con essa sviluppo e prosperità delle società umane. Il loro operare concorre a determinarli in vari modi e misure, ma una particolare preoccupazione deriva dal ruolo dell’agricoltura – attività diffusa su tutte le terre emerse e libere da ghiacci e che crescentemente risponde a un modello dominante intensivo di elevato impatto ambientale- considerata considerata” major driver” dei sistemi terrestri che superano i confini planetari. I suoi impatti derivano dalla diffusione di coltivazioni, allevamenti e pascoli su circa il 40% della superficie planetaria. A essa vanno anche imputati consumi idrici, per evapotraspirazione e per l’irrigazione, pari al 70% dell’acqua dolce disponibile e alterazioni nei cicli biogeochimici dell’Azoto e del Fosforo, soprattutto per i fertilizzanti di sintesi, con gravi fenomeni di inquinamento dei sistemi acquatici e costi ambientali considerati superiori ai benefici. Le attività agricole comportano anche effetti negativi sull’integrità della biosfera per i cambiamenti d’uso del suolo e per la collegata semplificazione ecosistemica. La biodiversità, in particolare, è fortemente intaccata con un tasso di estinzione delle specie stimato pari al 5 -10% per decade. All’agricoltura va anche imputata grande responsabilità circa i cambiamenti climatici (da essa proviene, secondo diverse stime, dal 14 al 24% delle emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti, l’acidificazione delle acque (aumento del 34% dall’inizio del XIX secolo, con massima responsabilità della CO2), la riduzione dell’ozono stratosferico che vede implicate non solo le emissioni di CFC (il cui uso è oggetto da anni di drastiche restrizioni) ma anche quelle di ossidi di azoto derivate dai fertilizzanti. Tra i rischi globali derivanti dal superamento dei PB si considerano gli incrementi dell’aerosol atmosferico, che comporta alterazione del bilancio energetico oltre che danni diretti alla salute umana, e l’introduzione di nuovi principi attivi (particolarmente in agricoltura) provenienti dalla chimica di sintesi, dalle biotecnologie, dalla ricerca genetica. Con differenze rilevanti tra aree geografiche, la soglia di rischio per alcuni PB è stata superata: in particolare quella dei flussi biochimici di N e P e quella della diversità genetica e per entrambe l’incidenza delle attività agricole risulta preminente. Le stesse sono fortemente coinvolte nel rischio crescente che proviene dai cambiamenti climatici e da quelli relativi all’uso del suolo.
Le generali condizioni di rischio (in aumento anche per gli altri fattori seppure non sempre facilmente determinabili) sono considerate in aggravamento per il previsto aumento della popolazione umana (9,7 miliardi nel 2050 secondo l’ONU, 2015), per l’incremento delle superfici agricole, per i rischi ambientali che derivano dall’applicazione del dominante sistema agricolo monocolturale e per la diffusione di una dieta ampiamente basata sul consumo di carne. Secondo il rapporto FAO 2018, la fame nel mondo oggi riguarda 821 milioni di persone i cui fabbisogni alimentari potrebbero essere soddisfatti da un più efficiente e razionale uso delle risorse. Ciò non sarebbe però possibile con l’incremento della popolazione ai valori previsti, perché in tal caso i bisogni alimentari sarebbero soddisfatti solo a condizione di un pericoloso innalzamento delle soglie di rischio. Basti considerare la tendenza all’aumento della deforestazione per la messa a colture di nuove aree (soprattutto nei tropici e non bilanciata dall’incremento delle aree forestali in molti paesi delle zone temperate), all’inquinamento da azoto e fosforo, all’aumento dei consumi idrici (più 19% al 2050).
Al superamento dei limiti planetari contribuiscono sia i singoli processi che l’interazione tra essi. Il contenimento necessita quindi di una valutazione sistemica che consideri insieme le funzioni produttive, quelle ambientali e le culturali. E’, del resto, consolidata la consapevolezza che l’agricoltura vada considerata “in ordine ai benefici multipli forniti al genere umano” dai servizi ecosistemici che così elenca il Millennium Ecosystem Assessment (2005): “di fornitura o approvvigionamento” di beni veri e propri quali alimenti e materie prime; “di regolazione” del clima, della qualità dell’aria e delle acque, la formazione del suolo e la mitigazione dei rischi naturali; di “supporto” relativamente agli habitat e alla biodiversità; “culturali” che includono benefici non materiali quali i valori e l’identità culturale, l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi. Nei sistemi multifunzionali, le tecniche agricole non possono limitarsi a un susseguirsi, lungo la filiera produttiva, di singole pratiche virtuose ma devono rispondere a una visione integrata dei processi -quindi non riduzionista -che vada oltre i singoli momenti colturali, i confini del campo coltivato e comprenda le fasi della trasformazione e della commercializzazione fino al consumo. Il superamento dei confini di sicurezza mette definitivamente in crisi il paradigma produttivista celebrato nel 1970 con il premio Nobel assegnato a Norman Borlaug per i successi dell’agricoltura industriale monocolturale ottenuti, grazie all’impiego massiccio dell’energia fossile e della chimica di sintesi, attraverso la semplificazione genetica, agronomica, ecosistemica e paesaggistica a scapito degli equilibri garantiti dalla complessità, dalla circolarità dei materiali e dell’energia (per il rapporto con la zootecnia) propria delle tradizionali policolture. Erano gli anni della “rivoluzione verde”, che (ben oltre il nome accattivante) coincidevano con quelli della “grande accelerazione” e che ha portato a risultati quantitativi che solo per un breve periodo sono riusciti a nascondere i disastri ambientali derivanti dall’uso imponente di pesticidi e fertilizzanti e l’emergere di una crisi sociale che investiva i protagonisti principali, fuggiti o cacciati dalle campagne. Negli stessi anni iniziava, però, a prendere consistenza una diversa visione dell’agricoltura che, pur rifacendosi a teorie filosofiche diffuse nella prima parte del secolo ma rimaste minoritarie, aveva trovato solide basi scientifiche nelle conoscenze sistemiche, nel dialogo interculturale, in una nuova etica ambientale, in un’attenzione ai diffusi saperi tradizionali sopravvissuti al trionfo delle macchine e della chimica, nella sistematizzazione di un sapere agronomico capace di tenere insieme millenni di positive evidenze colturali con le scoperte della nuova scienza biologica, ecologica, agronomica. La cultura alternativa degli anni Sessanta (che si mostrava anche con l’appariscenza degli hippy, dei figli dei fiori, delle comuni rurali a carattere libertario), ha accompagnato nuove (o rinnovate) visioni dei sistemi agricoli.
Agroecologia, paesaggio
La critica più evidente ai sistemi dell’agricoltura intensiva contemporanea è data dal successo internazionale dell’agricoltura biologica o come variamente è inteso (organica, biodinamica, permacoltura…) quel modello produttivo che esclude pesticidi, fertilizzanti chimici di sintesi e promuove le rotazioni colturali e la circolarità dei nutrienti anche ai fini di incrementare i contenuti di sostanza organica nel suolo e con essa la fertilità variamente intesa. Un modello che può però ridursi alla sola sostituzione dei mezzi di produzione (da quelli della chimica di sintesi verso gli organici) per accedere a mercati attenti alla qualità delle produzioni e sensibili alle tematiche ambientali e sanitarie. In tal caso affronta solo in superficie i temi posti dagli impatti dell’agricoltura industriale e non guarda alla complessità del processo produttivo, lungo il percorso che dal campo giunge alla tavola del consumatore. Non soddisfa così all’esigenza di un approccio non riduzionista che metta in relazione le scienze agronomiche con quelle ecologiche e della pianificazione territoriale, con le esigenze culturali e sociali delle popolazioni rurali e dei consumatori, consentendo di raggiungere obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e culturale che trascendano i confini del singolo agrosistema. Il riferimento al sapere agronomico su cui si fonda l’agricoltura biologica è nella scienza dell’Agroecologia, nata negli anni 80 e mirata all’applicazione dei concetti dell’ecologia al campo coltivato. Il suo campo di intervento si è nel tempo ampliato e, venti anni dopo, è diventata “l’ecologia dell’intero sistema alimentare” che prevede un approccio transdisciplinare che interessa tutte le forme di conoscenza ed esperienza nel cambiamento del sistema alimentare. E’correlata all’ecologia ma anche all’economia e al sociale; è partecipativa in quanto richiede il coinvolgimento di tutte le parti interessate dalla fattoria alla tavola. “L’approccio si basa sul pensiero ecologico in cui è richiesta una comprensione olistica del sistema alimentare”. Non guarda, quindi, solo alle funzioni produttive, ma anche a quelle ambientali, culturali, sociali. Interessa le fasi di produzione, trasformazione, consumo e, con essi, la complessità dei rapporti tra uomo e natura. Consente di comprendere e affrontare il ruolo dell’agricoltura nella complessità, anche se non dichiara esplicitamente la nozione di paesaggio. Questo, non inteso nei limiti posti e applicati dalla Landscape Ecology (il paesaggio come “gruppo di ecosistemi interagenti”), ma nel senso di Paesaggio Culturale, “opera combinata della natura e dell’uomo” (UNESCO, 2005), riguarda non solo gli aspetti fisici, chimici, biologici della biosfera ma anche le necessità delle popolazioni, di quelle rurali e non solo; la loro cultura esprime bisogni anche immateriali, espressioni artistiche. Affrontare l’Antropocene, in modo che l’agricoltura non superi i limiti dei PB, ha bisogno di un approccio paesaggistico e attraverso esso questa si relaziona con le altre attività dell’uomo, con i diversi bisogni, con le altre componenti della biosfera. Della sua necessità sono divenute via via più consapevoli, nei loro recenti sviluppi, le scienze dell’agroecologia, dell’ecologia del paesaggio e l’attività di organismi internazionali quali UNESCO e FAO. Ciascuno per la parte che compete, riconosce che il paesaggio è il risultato dell’interazione tra i caratteri della natura e la storia dell’uomo che li ha modificati a proprio vantaggio, per i bisogni alimentari o di materie, per la sicurezza, per i piaceri. E’espressione del progetto di società i cui bisogni, materiali e immateriali, si riconoscono nei servizi ecosistemici e possono cambiare in relazione ai tempi della natura e dell’uomo: il paesaggio, nella dinamicità connaturata, è in grado di confrontarsi con il futuro e di adeguarsi a esso, alla sua inevitabile imprevedibilità. Alle domande che si porranno, ai bisogni che nasceranno dalla storia passata e presente di una comunità attraverso la partecipazione, la condivisione, l’incontro di saperi diversi. Il paesaggio è risultato della cultura di un popolo, esprime attraverso sé stesso o le forme che lo rappresentano i valori estetici (la bellezza) e confrontando i bisogni personali e della collettività con risorse e vincoli della natura (vivente e non) con cui interagisce, si relaziona con l’etica. Attraverso il paesaggio (il suo governo, il suo progetto) si possono cercare e trovare risposte alle domande dell’Antropocene.
Adesso che si è consapevoli che “il progetto moderno di assoggettare una natura inerte è stato sostituito dall’incubo di una natura che si ribella” la visione propria del paesaggio ha urgenza del passaggio dalla frammentazione nozionistica a una conoscenza multi e transdisciplinare utile a diverse scale (locale, globale), al confronto con le diverse culture umane, con le necessità sociali, con una dinamicità che consenta elasticità rispetto a un futuro che può prevedersi ma non conoscere. Un’analisi sul ruolo dell’agricoltura sui limiti di sicurezza del sistema planetario si chiude affermando che “è necessario niente di meno che un sistema radicalmente trasformato, con numerosi cambiamenti in tutti gli aspetti della produzione, con attenzione alla gestione del paesaggio e ai cambiamenti in tutto il food system“. Conferma quanto sia urgente “un sostanziale cambiamento culturale, anzi lo sradicamento di un paradigma e l’affermazione di uno nuovo in cui le scelte, anche quelle personali, si muovano all’interno di un pentagono ai cui vertici stanno le cinque E: Etica, Estetica, Economia, Ecologia, Energia.
Paesaggi Rurali
Ha scritto Rosario Assunto che “il paesaggio contemporaneo è il paesaggio di un mondo nel quale l’uomo ha sacrificato alla produttività la propria dimensione contemplabile, ha sacrificato il proprio essere qualitativo ad una efficienza produttrice di quantità” E così negli anni dell’Antropocene, nelle aree più favorite per caratteri ambientali e idonee a ospitare i sistemi propri dell’agricoltura industriale, i processi di intensificazione hanno perseguito il diffondersi di ordinamenti monoculturali caratterizzati da paesaggi banali ed omologhi, tipici delle pianure irrigue e definibili come paesaggi-industria. Nel contempo, nei pressi delle grandi città, il paesaggio ha perso la sua omogeneità strutturale per frammentarsi e diventare il paesaggio dell’agricoltura periurbana nel quale città e campagna si congiungono in uno spazio misto, ibrido, senza identità: un paesaggio supermarket che sarebbe, dove manca il controllo della crescita urbanistica, meglio definire paesaggio discarica, costituito da manufatti abusivi, immondezzai, opere pubbliche incompiute, aree agricole abbandonate e degradate. Nelle aree non idonee alla semplificazione e all’intensificazione, come nei territori di montagna, si è invece verificato un processo di marginalizzazione con la diffusione di paesaggi avviati alla seminaturalità attraverso l’abbandono delle attività e degli insediamenti, oppure all’estensivizzazione con la conversione a pascolo o il rimboschimento o, ancora, al degrado causato da incendi e processi erosivi. A nessuno di essi corrisponde un paesaggio che consenta di affrontare la crisi dell’Antropocene, poichè essi non corrispondono alla complessità ecosistemica e culturale che può essere propria dei paesaggi rurali e alla multifunzionalità da perseguire Non sono paesaggi “contemplabili”, non rispondono alla soddisfazione di bisogni solo economici o ambientali, ma rimandano a valori e piaceri al pari imprescindibili.
Anche i modelli biologici non risultano, se le innovazioni si limitano a singoli momenti dei processi produttivi, adeguati all’Antropocene Si è ritenuto che seppure possa essere certamente auspicabile una generale diffusione di sistemi biologici che forniscano cibo sufficiente ai bisogni dell’umanità e, allo stesso tempo, minimizzano gli impatti ambientali, ciò sarebbe possibile solo all’interno di un sistema che riduca l’allevamento animale intensivo, il consumo di carne ( secondo Lancet almeno del 50%), gli scarti e gli sprechi. La conversione totale ad un sistema di produzione biologico che mirasse a fornire le stesse quantità dell’attuale scenario agricolo comporterebbe un aumento della deforestazione con riflessi negativi sui cambiamenti climatici. Un’ampia conversione all’agricoltura biologica sarebbe però possibile solo mirando (e premiando) a obiettivi produttivi che considerino anche i benefici determinati dalla riduzione nell’uso dei fertilizzanti azotati e dei pesticidi, del mantenimento della fertilità del suolo, della biodiversità negli agrosistemi e dei vantaggi sanitari derivanti da un ridotto consumo di carne. A conclusioni simili giunge uno studio che riguarda l’UE e che disegna uno scenario basato sulla riconnessione tra produzione animale e vegetale, in una struttura paesaggistica eterogenea (attraverso prati stabili e pascoli montani), che porta all’abbandono dei pesticidi e degli azotati di sintesi. Fondamentale, anche in questo caso, un sobrio regime alimentare, ridotto in termini di calorie del 35%. Scenari radicali, estremi, tanto quanto, però, appaiono i rischi dell’Antropocene. Scenari comunque corretti in termini agroecologici e paesaggistici che mirano alla formazione di agrosistemi che assicurano la riproducibilità dei processi (il ciclo della materia e dell’acqua, i flussi di energia, l’equilibrio tra le popolazioni animali) che riducono o annullano la necessità di sussidi esterni e che sono alla base della conservazione e della fertilità del suolo. Guardando a tale obiettivo, lo spazio agrario andrebbe strutturato sia a livello di agrosistema (ad esempio con le consociazioni) che a livello aziendale (nell’integrazione con la zootecnia) ed ecosistemico (tra sistemi agrari, agroforestali e forestali ed essi con quelli urbani e infrastrutturali). Elevati livelli di diversità biologica, consentirebbero di disporre di prodotti diversificati e di un sistema che per il suo funzionamento ricorra a risorse e processi endogeni risultando autonomo dal punto di vista energetico e resiliente: in grado, nel caso di stress biotici o abiotici negativi, di mantenere o recuperare le sue funzioni. In tali contesti, inoltre la possibilità di dedicare ampie superfici alla coltivazione di biomasse energetiche o di dedicarle all’istallazione di impianti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili è considerata con preoccupata attenzione.
I paesaggi tradizionali
I paesaggi dei sistemi dell’agricoltura contemporanea che hanno portato a superare i limiti di sicurezza planetari, sono il risultato di visione riduzionista basata su singole o settoriali tecniche. Una visione sistemica, compiutamente di paesaggio, è in molte letture e politiche territoriali, limitata da punti di vista che ne limitano il valore a quello estetico o ecologico. I paesaggi sono però, per definizione, luoghi dell’incontro tra natura, storia e percezione e l’incontro che ne deriva è alla base della multifunzionalità (della fornitura di servizi ecosistemici) che è fondamentale per comprendere e affrontare la complessità dell’Antropocene. Tali caratteristiche, compiutamente sistemiche, sono alla base di molti paesaggi tradizionali (variamente definiti tradizionali o storici, agrari o rurali) sopravvissuti al successo dell’agricoltura industriale. Essi definiscono i sistemi agrari nei loro caratteri evolutivi storicamente sedimentati; l’attributo di tradizionalità riguarda non solo la persistenza storica dell’uso del suolo ma considera anche quella di funzioni ambientali, culturali, sociali, economiche che insieme denotano complessità. I paesaggi rurali tradizionali non sono valutati solo per il valore di heritage, di bene culturale da salvaguardare, né di riserva di biodiversità o come deposito di saperi immateriali: nel disegno spaziale considerano l’insieme che da tutto ciò deriva in relazione alla capacità di organizzare molteplici funzioni e gli interessi (materiali e immateriali) delle popolazioni. Sono configurazioni che rappresentano le complesse esigenze di sistemi sociali e culturali in continua evoluzione, assicurando i diversi servizi ecosistemici anche in vista dei cambiamenti globali attesi. Il modello che difendono e diffondono conserva sia la diversità biologica che culturale oltre i limiti della concezione delle aree protette dove questa porta a negare o fortemente ridurre le attività umane. Ai paesaggi tradizionali fanno riferimento i GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) dell’omonimo programma della FAO: Paesaggi eccezionali per bellezza estetica che combinano biodiversità culturale, ecosistemi resilienti e un prezioso patrimonio culturale. Situati in siti specifici in tutto il mondo, forniscono in modo sostenibile molteplici beni e servizi, cibo e mezzi di sussistenza per r milioni di piccoli agricoltori. […] Sfortunatamente, questi sistemi agricoli sono minacciati da molti fattori, tra cui i cambiamenti climatici e l’aumento della concorrenza per le risorse naturali. Hanno a che fare anche con la migrazione a causa della bassa redditività economica che ha portato all’abbandono delle pratiche agricole tradizionali e alla perdita di specie e razze endemiche. […] Questi ancestrali sistemi agricoli costituiscono la base per l’agricoltura contemporanea e per future innovazioni e tecnologie innovative. La loro diversità culturale, ecologico e agricola è ancora evidente in molte parti del mondo »”. La condivisione di una visione integrata di valori e funzioni, che superi la separazione tra beni materiali e immateriali, tra oggetti da difendere e attori della conoscenza che vi sottende, è stata recentemente ribadita dalla carta dei principi di ICOMOS IFLA (2017). Nei GIAHS i paesaggi tradizionali non vengono considerati in quanto monumenti ma come esempio del un rapporto felice tra il sapere degli uomini e l’ambiente. Non paesaggi ”boutique” oggetto di conservazione, ma paesaggi ai quali si garantisce la connaturata dinamicità, espressione di attiva coevoluzione tra uomo e natura.
——–
Convivere con l’Antropocene, contrastarne gli effetti distruttivi per l’umanità e il pianeta, obbliga a rispettare limiti ambientali e correlati effetti economici e sociali attraverso uno sforzo globale che vada oltre i confini geopolitici, le culture, i rapporti intergenerazionali. L’Antropocene coinvolge tutta l’umanità che l’ha determinato, indipendentemente dai tempi e dalle responsabilità e la pone in relazione con la biosfera del pianeta: tanto è sistemico nel suo manifestarsi, tanto sistemico deve essere il modo di convivere in esso e contrastarne gli effetti negativi. L’unico modo per cui ciò avvenga è attraverso il paesaggio. E’ nel suo disegno che si collegano i rapporti tra uomo e natura nelle diverse manifestazioni possibili (quelle sopradette del cinque E) e sarà un nuovo paesaggio che mostrerà i nuovi rapporti. Si rimanda, ancora, a Rosario Assunto: “… il paesaggio è natura nella quale la civiltà rispecchia sè stessa, riconosce se stessa, immedesimandosi nelle sue forme; le quali, una volta che la civiltà, una civiltà con tutta la sua storicità, si è in esse riconosciuta, si configurano ai nostri occhi come forme, a un tempo, della natura e della civiltà”. Gli anni che viviamo sono quelli della “grande cecità”: non vediamo in segnali che sono evidenti (le conseguenze del superamento dei PB, il deteriorarsi dei rapporti interculturali, l’incapacità di gestire le grandi migrazioni, le crescenti tensioni politiche) il procedere verso disastri crescenti. Nel paesaggio, nei suoi equilibri millenari dove ancora permangono, nella resilienza che da essi proviene è possibile ritrovare nuovi equilibri. Lo testimoniano nuove sensibilità culturali, alcune con profonde radici religiose (la visione ecosistemica di Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sii, il neo confucianesimo..,), altre saldamente ancorate alle diverse scienze, pur tra grandi contraddizioni (il perdurare dell’imperialismo e del colonialismo, l’etica dominante capitalistica, il mancato rispetto dei diritti umani…). Ora si tratta di pianificare, progettare, realizzare e gestire nuovi paesaggi che siano evidenza di un rapporto tra l’uomo e la natura non distruttivo e dominante. Anche nel paesaggio va messo in discussione l’antropocentrismo: gli interessi dell’uomo, in una nuova e più ampia visione etica, vanno a coincidere con quelli dell’intera biosfera.
L’Antropocene impone diverse strategie di contenimento. Alcune – lo indicava già Crutzen nel 2002- si affidano a nuove tecnologie (in agricoltura l’esempio dei cosiddetti OGM è il più noto), altre confidano nelle pratiche dell’agricoltura biologica, altre ancora si affidano alla capacità dell’uomo di arrivare ad una cultura “ibrida” tra naturale e artificiale.
Alla cura dell’uomo, al suo manifestarsi nel paesaggio è, concretamente e non fideisticamente, legata la risposta che proviene da Emilio Sereni quando definendo il paesaggio agrario lo dice risultato dell’uomo attraverso attività che imprime “coscientemente e sistematicamente al paesaggio naturale». I due avverbi qualificano la responsabilità alla quale si è chiamati. Coscientemente, perché si abbia consapevolezza di sé, del rapporto con il mondo esterno e degli effetti su di esso espressi. Sistematicamente, perché si abbia cognizione di intervenire in un insieme complesso, la cui somma va ben oltre le singole parti che lo compongono, i saperi che lo determinano, gli effetti che, nel tempo e nello spazio, si producono.