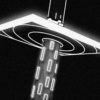Era il 1979 quando Jules Charney, il padre della meteorologia moderna, pubblicò un rapporto che diceva, senza ombra di dubbio, che l’umanità era sull’orlo di una catastrofe causata dal riscaldamento globale provocato dalle emissioni di CO2. L’affermazione derivava dalle simulazioni fatte dal grande esperto di modelli di simulazione James Hansen, che due anni dopo sarebbe diventato il direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA. Anche l’EXXON sapeva cosa stava succedendo, attraverso gli studi svolti dai propri ricercatori: un rapporto interno, consegnato ai vertici dell’azienda, mostrava inequivocabilmente la relazione fra le emissioni di CO2 e il riscaldamento globale, con previsioni catastrofiche se si continuava a bruciare combustibili fossili.
Dopo la pubblicazione del rapporto, Jimmy Carter firmò l’Energy Security Act del 1980, che ordinava alla National Academy of Sciences di avviare uno studio pluriennale e completo, chiamato “Changing Climate”, che avrebbe analizzato gli effetti sociali ed economici del cambiamento climatico. Il 19 ottobre 1983, la commissione annunciò finalmente i suoi risultati, mentre presidente degli USA era diventato Reagan. Il rapporto prodotto dalla commissione sostanzialmente confermava quanto era stato già scritto nel rapporto di Charney, pubblicato quattro anni prima. Peccato che il presidente della commissione, William Nierenberg, nelle interviste sostenesse invece che non c’era alcuna urgenza per agire. Ci voleva cautela, non panico. Bisognava aspettare e vedere.
Sì, il clima sarebbe cambiato, prevalentemente in peggio, disse Nieremberg, ma le generazioni future sarebbero state meglio attrezzate per adattarsi, e la stampa si guardò bene dall’andare a leggere il rapporto, troppa fatica per un argomento così poco attraente per il grande pubblico; fosse stato un omicidio avrebbero digerito migliaia di pagine di sentenze. Nieremberg era uno che credeva nelle straordinarie capacità dell’uomo, in particolare l’uomo americano, e nella tecnologia, che avrebbe risolto tutti i problemi, e credeva pure nelle grazie salvifiche delle forze di mercato. Ricorda molto un nostro ministro, chiamato a gestire la transizione ecologica. Qualcosa, comunque, cominciò a muoversi, sia pure molto lentamente. Infatti nel 1987, quattro anni dopo il rapporto “Changing Climate”, due anni dopo la scoperta del buco dell’ozono e un mese dopo che gli Stati Uniti e una quarantina di altre nazioni avevano firmato un trattato per limitare l’uso dei CFC, era ormai opinione comune che il cambiamento climatico avrebbe seguito la traiettoria dell’ozono.
Il Congresso aveva già iniziato a prendere in considerazione la tematica: solo nel 1987 ci furono otto giorni di audizioni sul clima, in tre commissioni al Congresso e al Senato. Addirittura il senatore Joe Biden (ma guarda un po’), aveva proposto un progetto di legge per definire una strategia nazionale per il cambiamento climatico. In una di queste audizioni fu invitato James Hansen che, pur essendo a capo di un prestigioso laboratorio scientifico governativo, si presentò come privato cittadino, per una buona ragione: proprio perché capo di una istituzione governativa era tenuto a inviare il testo delle sue dichiarazioni in anticipo a un ufficio governativo che, dopo averlo visionato ed eventualmente emendato, lo avrebbe trasmesso alla Casa Bianca per approvazione. Il fatto è che gli era stato chiesto di apportare modifiche nel punto in cui aveva scritto che si poteva affermare con certezza che il cambiamento climatico fosse causato dall’aumento di concentrazione di CO2 e altri gas a causa dell’effetto serra e che per questo entro il 2010 l’intero globo si sarebbe riscaldato in modo sostanziale.
Dopo le audizioni, Timothy Wirth, un senatore democratico del Colorado membro della commissione energia, iniziò a mettere a punto un pacchetto completo di leggi sul cambiamento climatico, un New Deal per il riscaldamento globale. Nel marzo 1988, assieme ad altri 41 senatori, quasi la metà dei quali repubblicani, Wirth chiese a Reagan di spingere per un trattato internazionale, sul modello dell’accordo sull’ozono. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, essendo i due maggiori contributori mondiali di emissioni di CO2, avrebbero dovuto guidare i negoziati. Reagan era d’accordo. A maggio, firmò una dichiarazione congiunta con Mikhail Gorbaciov che includeva un impegno a cooperare sul riscaldamento globale. Ma un impegno non riduce le emissioni. E lo sappiamo oggi fin troppo bene con gli impegni presi a Parigi nel 2015. Così, nonostante gli sforzi di Wirth, non c’era alcun piano serio a livello nazionale o internazionale per affrontare il cambiamento climatico.
Il 23 giugno 1988, a Washington, James Hansen era stato chiamato a rendere una testimonianza in una commissione senatoriale convocata da Timothy Wirth. Quanto detto da Hansen in quella occasione era così allarmante da arrivare sulle prime pagine dei principali giornali, tra cui il New York Times, che titolava: “Il riscaldamento globale è iniziato, afferma l’esperto al Senato”. Appena quattro giorni dopo, i politici di 46 nazioni e più di 300 scienziati si sarebbero riuniti a Toronto alla ‘Conferenza mondiale sull’atmosfera che cambia’, un evento descritto sul New York Times come “la Woodstock del cambiamento climatico”. Wirth, forte dei dati scientifici resi noti da Hansen nel corso della audizione di pochi giorni prima, nel suo intervento a Toronto il 27 giugno chiese al mondo di ridurre le emissioni del 20% entro il 2000. La dichiarazione finale della conferenza, firmata da tutti i 400 scienziati e politici presenti, accolse la richiesta con una leggera variazione: una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2005.
Sembrava proprio che fossimo vicini ad azioni vere, decise, per combattere il cambiamento climatico, tanto che durante la campagna elettorale in corso George Bush dichiarò: ‘coloro che pensano che siamo impotenti a fare qualcosa per l’effetto serra si stanno dimenticando dell’effetto Casa Bianca’. Poco dopo il parlamento tedesco istituì una commissione speciale sul cambiamento climatico, che concluse che bisognava agire immediatamente, “a prescindere da qualsiasi necessità di ulteriori ricerche”, e che l’obiettivo di Toronto era inadeguato e raccomandò una riduzione del 30% delle emissioni di CO2. I primi ministri di Canada e Norvegia chiesero un trattato internazionale vincolante sull’atmosfera. Il Parlamento svedese andò oltre, annunciando una strategia nazionale per stabilizzare le emissioni al livello del 1988 e infine imponendo una carbon tax. Margaret Thatcher, che aveva studiato chimica a Oxford, in un discorso alla Royal Society mise in guardia sul fatto che il riscaldamento globale potrebbe “superare di gran lunga la capacità del nostro habitat naturale a fargli fronte” e che “la salute dell’economia e la salute del nostro ambiente sono totalmente dipendenti l’uno dall’altro”. Incredibile la faccia tosta dei politici, possiamo dire oggi, sapendo come è andata.
Fu in quel momento – in un momento in cui il movimento ambientalista piangeva dalla gioia, come ebbe a dire un lobbista delle fonti fossili – che le Nazioni Unite approvarono all’unanimità l’istituzione, da parte del WMO e dell’UNEP, di un gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, composto da scienziati e responsabili politici, per condurre valutazioni scientifiche e sviluppare una politica climatica globale, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Una delle prime sessioni dell’IPCC per pianificare un trattato internazionale fu ospitata dal Dipartimento di Stato degli USA, 10 giorni dopo l’insediamento di Bush. James Baker, appena nominato Segretario Stato, colse l’occasione per fare il suo primo discorso, affermando: “Probabilmente non possiamo permetterci di aspettare che tutte le incertezze sul cambiamento climatico globale siano state risolte”, affermò. Dopo l’intervento all’IPCC Baker ricevette la visita di John Sununu, capo dello staff di Bush, che gli disse: “Lascia la scienza agli scienziati. Stai alla larga da queste sciocchezze sull’effetto serra. Non sai di cosa stai parlando”.
In aprile Richard Darman, il direttore dell’OMB (quell’ufficio preposto al controllo preventivo delle dichiarazioni pubbliche dei vertici delle istituzioni governative che aveva tanto stravolto l’intervento di Hansen a una audizione parlamentare da indurlo a presentarsi come privato cittadino), che era uno stretto alleato di Sununu, comunicò che lo scienziato della NASA James Hansen sarebbe stato convocato di nuovo per una audizione parlamentare, convocata da Al Gore. Darman aveva ricevuto il testo delle dichiarazioni che avrebbe fatto Hansen e lo sintetizzò a Sununu che ne fu sgomento: il linguaggio di Hansen gli sembrava estremo, basato su argomenti scientifici che considerava, come ebbe a dire in seguito, “immondizia tecnica”. Nella prima settimana di maggio 1989, quando Hansen ricevette dall’OMB la versione revisionata del suo intervento all’audizione, la trovò sfigurata da tagli e, cosa più incredibile, aggiunte. Il testo modificato era un disastro. Per un paio di giorni, Hansen provò a lavorarci sopra, accettando le modifiche più innocue. Ma non poteva accettare alcune delle frasi proposte. Con l’udienza a soli due giorni di distanza, rinunciò e scrisse una lettera a Gore. Gli spiegò che l’OMB voleva che chiamasse le sue certezze scientifiche “stime” derivanti da modelli “in evoluzione” e “inaffidabili”. Il suo anonimo censore voleva che affermasse che le cause del riscaldamento globale erano “scientificamente non provate” e che potevano essere attribuite a “processi naturali”; le quali affermazioni avrebbero reso le sue dichiarazioni prive di senso e, per di più, lo avrebbero fatto sembrare un idiota. L’aggiunta più bizzarra, tuttavia, era qualcosa di diverso. Gli si chiedeva di sostenere che il Congresso avrebbe dovuto approvare solo leggi sul clima che avvantaggiassero direttamente l’economia, “indipendentemente dalle preoccupazioni per un aumento dell’effetto serra”. Una frase che nessuno scienziato pronuncerebbe mai, a meno che forse non fosse al soldo delle multinazionali del petrolio.
Ricevuta la lettera, Gore, dopo avergli chiesto il permesso, mise al corrente del tutto un paio di giornalisti e concordò con Hansen che la sua dichiarazione sarebbe stata resa secondo il testo emendato dall’OMB. Dopo che Hansen ebbe letto la sua dichiarazione come voluta dall’OMB, Gore intervenne. Era perplesso dalle incongruenze nella presentazione dell’illustre scienziato, disse con un tono denso di finta confusione. “Perché si contraddice così apertamente?”. Hansen spiegò che non aveva scritto quelle dichiarazioni contraddittorie, ma gli erano state imposte. “L’amministrazione Bush si sta comportando come se avesse paura della verità”, disse Gore. “Se la hanno costretto a cambiare una conclusione scientifica, questa è una forma di frode scientifica”.
L’audizione ebbe grande eco, e la censura finì per pubblicizzare i pericoli del riscaldamento globale più di qualsiasi cosa Hansen avesse potuto dire. Il giorno dopo l’audizione, Gore ricevette una visita senza preavviso del direttore dell’OMB. Venne da solo e disse che voleva scusarsi di persona. Poi Darman andò a trovare Sununu. Non gli piaceva essere accusato di censurare gli scienziati. Bisognava dare una qualche risposta rassicurante. Sununu chiamò il direttore dell’EPA Reilly per chiedere se avesse qualche idea. Potremmo iniziare, disse Reilly, impegnandoci nuovamente in un trattato globale sul clima, visto che siamo stati l’unica nazione occidentale contraria ai negoziati.
Così sappiamo che l’era Trump è stata un revival: il lupo perde il pelo…
Il 6 novembre 1989, sulla costa del Mare del Nord nella località turistica olandese di Noordwijk, le delegazioni dovevano esaminare i progressi compiuti dall’IPCC e decidere se approvare una struttura di trattato globale. “Cosa sta succedendo?” urlò Becker, del Sierra Club, per la centesima volta, quando il ministro svedese venne fuori dalla sala riunioni inaccessibile ad altri che non fossero funzionari governativi e ministri o capi di stato. “Il tuo governo”, disse il ministro, “sta mandando tutto a rotoli”. Allan Bromley, un fisico nucleare di Yale, uno dei delegati principali degli Stati Uniti, su sollecitazione di John Sununu e con l’acquiescenza di Gran Bretagna, Giappone e Unione Sovietica, aveva costretto i partecipanti alla conferenza ad abbandonare l’impegno a congelare le emissioni. La dichiarazione finale rilevò solo che “molte” nazioni avevano sostenuto la stabilizzazione delle emissioni, senza indicare quali nazioni a quale livello di emissioni. E con ciò, un decennio di progressi difficili, dolorosi ed esaltanti finì nel nulla.
Le multinazionali del petrolio, del gas, del carbone e dell’auto avevano vinto, grazie all’azione combinata di lobbying, ricatti politici e di cospicui investimenti nella disinformazione, instillando nei media e nella opinione pubblica una falsa percezione di incertezza da parte della comunità scientifica in merito alle cause o addirittura alla esistenza stessa del cambiamento climatico. Incertezza che invece non c’era proprio. E giocando su questa incertezza hanno ottenuto l’inazione.
Quale è la morale di questa cronaca? Beh, ci sono almeno un paio di morali. La prima è che quando la scienza e il denaro si scontrano vince il denaro, dei pochi che ne hanno tanto, a danno dei molti che ne hanno poco. La seconda è che la vittoria ha trovato facile strada in quei molti che credevano e continuano a credere nell’onnipotenza dell’uomo e della sua capacità di superare qualsiasi ostacolo, anche quello posto dalle leggi della fisica, che sono quelle che regolano la natura.
Oggi si sta ripetendo lo stesso copione. Con le stesse forze in campo che si contrappongono: scienza contro avidità. Da una parte la comunità scientifica e le associazioni ambientaliste che su di essa basano le proprie azioni e dall’altra le potenti lobby che raccolgono gli azionisti di tutte le aziende che avrebbero qualcosa da perdere se si dovesse seriamente combattere il cambiamento climatico e il degrado ambientale in genere. Oggi, fra l’altro, il numero e la varietà dei soggetti che si coalizzano contro qualsiasi serio tentativo di restaurare un rapporto equilibrato fra uomo e natura si è ampliato, rispetto agli anni ’80 del secolo scorso. Si è ampliato perché nel frattempo sempre più persone hanno preso coscienza di qualcosa che peraltro era già noto alla comunità scientifica fino dai primi anni ’70, e cioè che il degrado ambientale si può fermare solo cambiando radicalmente il paradigma su cui si basa il nostro sistema economico e culturale. Inoltre, mentre allora l’attenzione era puntata solo sulle fonti fossili, oggi si ha ben chiaro che le responsabilità del sistema agroindustriale non sono da meno, come non lo sono quelle delle corporation delle plastiche monouso, quelle dei tessuti, eccetera. Ed ecco che la COP 26, a Glasgow, ha visto folte rappresentanze di lobbysti, in molti casi infiltrati nelle stesse delegazioni governative, appartenenti non solo alle compagnie Oil&Gas, del carbone e dell’auto, ma anche alla Nestlé, alla Bayer, alla Coca Cola, all’Unilever, a distributori come Sainsbury’s, ai colossi della Big Meat (JBS, Tyson, Cargill), ai grandi produttori di oggetti di plastica monouso, alla fast fashion (Zara, H&M, ecc.), e in generale a tutti quelli che si avvantaggiano del consumismo, che una vera lotta al degrado ambientale dovrebbe mettere fuori gioco.
E tutti questi, coalizzati, hanno vinto. E stanno vincendo pure nella Europa del Green Deal, ottenendo che venga accettato l’assurdo secondo cui gas e nucleare vengano classificate come fonti energetiche “verdi”, sostenibili, nella tassonomia europea, e quindi verde diventa pure il CCS e verde diventa pure l’idrogeno blu, puro daltonismo. E così le Oil&Gas e le multinazionali del nucleare potranno ottenere i finanziamenti pubblici o addirittura contributi a fondo perduto attraverso il PNRR. Siamo all’aberrazione più totale, giocata anche sul fronte della comunicazione, con una azione spudorata di greenwashing.
E il problema è anche che, oggi come negli anni ’70 e ’80, il modello culturale corrente è centrato sulla esaltazione del superfluo, del sostanzialmente inutile, prova ne sia lo squallido panorama di start-up “innovative” e “sostenibili” che propongono improbabili prodotti che finiscono per avere il solo risultato di aumentare il prelievo di risorse naturali dall’ambiente, giocando sulla cultura ormai solidamente introiettata del consumo come valore, invece della sobrietà.
E c’è poi chi gioca sull’equivoco, come nel caso dell’Italia, dove – spinto dalle aziende interessate – il governo fraintende il concetto di economia circolare e lo sovrappone, tout court, a quello di riciclo, finanziandolo con i fondi del PNRR. Il riciclo è cosa giusta e utile nel transitorio, ma solo se unito a un forte sostegno, contemporaneamente, alla parte vera dell’economia circolare, quella che – se messa in atto – minimizza l’estrazione di risorse naturali dall’ambiente e quindi minimizza anche la quantità di rifiuti da riciclare attraverso la progettazione di prodotti durevoli, riparabili, riusabili, riadattabili, eccetera. Sostenendo solo il riciclo, invece, il risultato è che la lobby dei riciclatori, resa più forte, non permetterà di mettere in atto la minimizzazione dei rifiuti che è l’obiettivo finale dell’economia circolare, perché minimizzare i rifiuti da riciclare significa minimizzare il business.
L’occasione perduta del 1989 rischia di ripetersi nel 2021-2022, con la differenza che nessuno osa più mettere in dubbio il cambiamento climatico e le sue cause, e quindi la coalizione del business e della finanza ha cambiato strategia, puntando sulla dilazione, cercando di rallentare la trasformazione del sistema economico e sociale, cioè il pieno dispiegamento delle fonti rinnovabili e la completa ed effettiva realizzazione dell’economia circolare. Rallentando il processo di trasformazione, fra qualche anno – di fronte al crescere dell’emergenza ambientale – sarà troppo tardi per potere metterlo in atto, bisognerà necessariamente relegare in un angolo minoritario le fonti rinnovabili e invece puntare sul nucleare e sul CCS per continuare a bruciare metano come prima; continuare a devastare l’ambiente favorendo l’economia lineare (estrai, produci, consuma, getta) temperata (per modo di dire) dal riciclo e relegando in un angolo l’economia circolare. Ma questa volta il ritardo nell’azione ci porta senza scampo alla catastrofe. Se c’era ancora un po’ di tempo allora, negli anni ‘80, e i cambiamenti da apportare erano relativamente “soft”, non lo sono più oggi.
Fra trent’anni, forse, una testata coraggiosa farà una indagine analoga a quella da cui sono tratte le notizie sopra riportate[1], relative agli anni 1979-1989, ma prendendo di mira il periodo che va dal 2015 al 2025; e purtroppo racconterà le stesse cose, in sostanza. Racconterà la stessa lotta fra chi persegue l’interesse pubblico e chi quello proprio a scapito di quello pubblico; la stessa lotta fra la comunità scientifica e quella del business, della finanza; la stessa totale subalternità della classe politica al potere economico e finanziario. Peccato che c’è il rischio serio che siano ben pochi quelli che potranno leggerla, la nuova inchiesta, perché intanto la sesta estinzione sarà in fase molto avanzata. A meno che quei giovani, quei movimenti che a Glasgow non hanno avuto la possibilità di essere presi sul serio, non prendano in mano la situazione mediante una protesta continua, senza sosta. Una forma di azione pacifica collettiva che faccia sentire il fiato sul collo a chi vuole mantenere le cose come stanno, e cominciando a fare male alle tasche degli azionisti, per convincerli – e quindi convincere la classe politica che li rappresenta e li protegge – a cambiare registro. Già, perché questi giovani cominciano ad avere ben chiaro che non hanno più niente da perdere se agiscono contro l’establishment, perché se tutto va avanti come è andato avanti finora, per loro non c’è futuro; e se c’è non è certo invidiabile.
Articolo pubblicato su QualEnergia 2/2022
[1] Nathaniel Rich, Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change, The New York Times 16/02/19 –